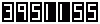Non può mancare un augurio di buon Natale e di felice 2020 a tutti gli amici del "Casello"... e il Casellante lo fa esponendo uno dei (rari) momenti di gioia autentica, almeno sul fronte calcistico!
Arrivederci nel 2020, al "Casello"!
LA TRISTEZZA, IL MAIALE, L'IGNAVA
Ebbene
sì: per chi ancora non se ne fosse accorto - e bisogna non avermi
frequentato, letto, compreso - dirò chiaro e tondo che amo la retorica.
Anzi, che non solo la amo e la pratico, ma non riesco proprio a
concepire modi di comunicare poveri nei contenuti e dimessi nella forma.
Di chi batte questa strada penso immediatamente male, un male selettivo
e irriducibile.
Amando la retorica, e quindi le sue implicazioni, amo un modo di essere identitario, forte, espressivo e poco incline ai compromessi ideali quanto capace di dialettica forte e inclusiva. Non una marmellata di idee diverse e spesso antipodiche confuse in quello che oggi viene chiamato (a torto, grazie al cielo) "pensiero unico", ma una sintesi o un confronto tra idee marcate e non necessariamente conciliabili. "Aut... aut...", più che "Et...et...".
Non ci sarà mai spazio dalle mie parti - faccio solo alcuni esempi - per chi sostiene che è "beato il popolo che non ha bisogno di eroi" (Bertolt Brecht), o per chi postula "Un'unica grande chiesa, che parte da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa". Guarda un po': penso, testimonio e pratico il contrario.
Parto da questo ampio preambolo per raccontare un episodio che mi è accaduto ieri.
Siamo a Genova Brignole, capolinea di uno dei molti autobus diretti verso il Levante. Sto parlando di lavoro, al telefono, con mio papà Argeo.
Al momento di salire sul mezzo, un cesso d'uomo grasso, barba incolta, grazia e stile da terzamedista, butta ostentatamente a terra tre grossi pezzi di carta in cui era avvolta la focaccia che - con la classe che immagino lo contraddistingua in ogni frangente - aveva appena terminato di fagocitare.
Sempre al telefono con papà, spontanea mi monta la carogna, con le sembianze di uno sguardo torvo e repressivo.
Il primate a sua volta mi guata in tralice, e mentre sale sul bus mi chiede, con espressione di sfida: "Vuole raccoglierla lei?".
Livello di saturazione raggiunto: "No, la raccolga lei! Lei l'ha buttata, lei la raccoglie e la butta in un cestino!".
"Non ci penso neanche!" - prosegue il bifolco, andandosi smaccatamente a sedere a centro autobus. - "E comunque, - aggiunge, - non sono cazzi suoi".
"Sono cazzi miei! - Gli grido dalla piattaforma posteriore dell'autobus, dove mi ero sistemato. - "Se tutti facessero come lei, questa città sarebbe un porcile!".
Temo di aver aggiunto anche un'interiezione non proprio delicata e una botta di "brutto maiale" al quadrumane. Mio padre, nel frattempo, mi dice: "Sento che hai da fare, ci sentiamo più tardi".
L'autobus nel frattempo è partito, lasciando dietro di sé la montagna di carta cacciata per terra dal subumano, con il quale continua la schermaglia a distanza.
Sono meravigliato del fatto che sull'autobus nessuno abbia fatto una piega. Mi sarei aspettato una levata di scudi contro il sudicione, anche perché, in un'epoca di ecologismo a basso costo, l'argomento sembra far presa.
L'unica, sorprendente reazione, invece, arriva da una signora in evidente deficit di presenza a se stessa. Ha vicino un bambino sui sette/otto anni, e sta parlando al telefono.
"Eh, cosa vuoi, ci sono qui due gran maleducati che parlano in modo così volgare, come se ci fossero solo loro, senza preoccuparsi minimamente che ci siano bambini ai quali far ascoltare le loro oscenità... eh, sì, devono discutere le loro questioni davanti a tutti...".
Sarebbe stato difficile, in quel preciso momento, trovare qualcosa che mi potesse far imbufalire di più. L'ignava che "né con lo Stato, né con le BR". Io e lo scimpanzé sullo stesso piano.
"Ha capito - le faccio presente - di cosa stavamo discutendo? Non siamo sullo stesso piano, io e quel... - lo indico, continua a guardarmi male ma non dice niente - quel maiale".
" A me non interessa di cosa stavate parlando. So solo che siete due maleducati, e che prima di dare certi esempi ai bambini dovreste badare alle parole che usate!".
"Ah! - Continuo io. - Ho capito che non ha capito. Mette sullo stesso piano un animale che butta un lenzuolo di carta per terra e chi glielo fa notare".
Prova a spiegarmi, seccata, che le attribuisco cose che non ha mai detto, ma ormai ho smesso di ascoltarla, e non ricordo nemmeno se il "Brutta bagascia" che mi sgorga dal cuore l'ho detto davvero o l'ho soltanto pensato.
Il finale triste - triste come me: triste solitario y final, per dirla con Osvaldo Soriano - è vedere gli altri passeggeri, muti. Codardi, rassegnati, più probabilmente "nonglienefregauncazzo". Non vorrei essere Greta Thunberg, è una battaglia persa.
P.S.: ormai, a detta della peppia che mi ha fatto la morale perché ho detto "cazzi miei" davanti al figlio, avevo perso la dignità. Così, quando il tanghero, uscito dall'autobus all'altezza di San Martino (non ricordavo ci fosse anche una clinica veterinaria), mi ha fatto il segno delle corna, non ho avuto scrupoli nel rispondergli in Eurovisione con quello delle mani a V sul cavallo dei pantaloni.
Amando la retorica, e quindi le sue implicazioni, amo un modo di essere identitario, forte, espressivo e poco incline ai compromessi ideali quanto capace di dialettica forte e inclusiva. Non una marmellata di idee diverse e spesso antipodiche confuse in quello che oggi viene chiamato (a torto, grazie al cielo) "pensiero unico", ma una sintesi o un confronto tra idee marcate e non necessariamente conciliabili. "Aut... aut...", più che "Et...et...".
Non ci sarà mai spazio dalle mie parti - faccio solo alcuni esempi - per chi sostiene che è "beato il popolo che non ha bisogno di eroi" (Bertolt Brecht), o per chi postula "Un'unica grande chiesa, che parte da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa". Guarda un po': penso, testimonio e pratico il contrario.
Parto da questo ampio preambolo per raccontare un episodio che mi è accaduto ieri.
Siamo a Genova Brignole, capolinea di uno dei molti autobus diretti verso il Levante. Sto parlando di lavoro, al telefono, con mio papà Argeo.
Al momento di salire sul mezzo, un cesso d'uomo grasso, barba incolta, grazia e stile da terzamedista, butta ostentatamente a terra tre grossi pezzi di carta in cui era avvolta la focaccia che - con la classe che immagino lo contraddistingua in ogni frangente - aveva appena terminato di fagocitare.
Sempre al telefono con papà, spontanea mi monta la carogna, con le sembianze di uno sguardo torvo e repressivo.
Il primate a sua volta mi guata in tralice, e mentre sale sul bus mi chiede, con espressione di sfida: "Vuole raccoglierla lei?".
Livello di saturazione raggiunto: "No, la raccolga lei! Lei l'ha buttata, lei la raccoglie e la butta in un cestino!".
"Non ci penso neanche!" - prosegue il bifolco, andandosi smaccatamente a sedere a centro autobus. - "E comunque, - aggiunge, - non sono cazzi suoi".
"Sono cazzi miei! - Gli grido dalla piattaforma posteriore dell'autobus, dove mi ero sistemato. - "Se tutti facessero come lei, questa città sarebbe un porcile!".
Temo di aver aggiunto anche un'interiezione non proprio delicata e una botta di "brutto maiale" al quadrumane. Mio padre, nel frattempo, mi dice: "Sento che hai da fare, ci sentiamo più tardi".
L'autobus nel frattempo è partito, lasciando dietro di sé la montagna di carta cacciata per terra dal subumano, con il quale continua la schermaglia a distanza.
Sono meravigliato del fatto che sull'autobus nessuno abbia fatto una piega. Mi sarei aspettato una levata di scudi contro il sudicione, anche perché, in un'epoca di ecologismo a basso costo, l'argomento sembra far presa.
L'unica, sorprendente reazione, invece, arriva da una signora in evidente deficit di presenza a se stessa. Ha vicino un bambino sui sette/otto anni, e sta parlando al telefono.
"Eh, cosa vuoi, ci sono qui due gran maleducati che parlano in modo così volgare, come se ci fossero solo loro, senza preoccuparsi minimamente che ci siano bambini ai quali far ascoltare le loro oscenità... eh, sì, devono discutere le loro questioni davanti a tutti...".
Sarebbe stato difficile, in quel preciso momento, trovare qualcosa che mi potesse far imbufalire di più. L'ignava che "né con lo Stato, né con le BR". Io e lo scimpanzé sullo stesso piano.
"Ha capito - le faccio presente - di cosa stavamo discutendo? Non siamo sullo stesso piano, io e quel... - lo indico, continua a guardarmi male ma non dice niente - quel maiale".
" A me non interessa di cosa stavate parlando. So solo che siete due maleducati, e che prima di dare certi esempi ai bambini dovreste badare alle parole che usate!".
"Ah! - Continuo io. - Ho capito che non ha capito. Mette sullo stesso piano un animale che butta un lenzuolo di carta per terra e chi glielo fa notare".
Prova a spiegarmi, seccata, che le attribuisco cose che non ha mai detto, ma ormai ho smesso di ascoltarla, e non ricordo nemmeno se il "Brutta bagascia" che mi sgorga dal cuore l'ho detto davvero o l'ho soltanto pensato.
Il finale triste - triste come me: triste solitario y final, per dirla con Osvaldo Soriano - è vedere gli altri passeggeri, muti. Codardi, rassegnati, più probabilmente "nonglienefregauncazzo". Non vorrei essere Greta Thunberg, è una battaglia persa.
P.S.: ormai, a detta della peppia che mi ha fatto la morale perché ho detto "cazzi miei" davanti al figlio, avevo perso la dignità. Così, quando il tanghero, uscito dall'autobus all'altezza di San Martino (non ricordavo ci fosse anche una clinica veterinaria), mi ha fatto il segno delle corna, non ho avuto scrupoli nel rispondergli in Eurovisione con quello delle mani a V sul cavallo dei pantaloni.
L'ESTATE, IL TEMPO DELLE SAGRE.
L'estate, purtroppo, scivola via
davanti al Casello, con grande scorno degli amanti di questa stagione
(il 73,8% della popolazione, cioè la netta maggioranza, secondo un
sondaggio che il Casellante si sta inventando in questo momento),
spargendo all'intorno il riverbero delle forti calure che anche in
questo inizio di settembre sembrano non voler abbandonare chi lavora
e chi si trastulla, ma anche tante piccole e grandi immagini che ci
faranno compagnia nelle tristi e grigie serate autunnali e invernali,
finchè una nuova primavera non farà capolino con le tenere gemme
verdoline...eccheppalle, persino il Casellante si rende conto che
questo primo articolo della nuova stagione sta venendo fuori una
schifezza, banale, retorico e noioso, quindi stop, prima che sia
troppo tardi.
Lascio all'invidia dei vostri amici e
parenti – yahoo! - il gusto di recensire i vostri album fotografici
del giro ai castelli della Loira o degli spritz a Filicudi. Qui
voglio trattare rapidamente di un fenomeno che sembra giacere in un
baule fino al termine della stagione scolastica per poi
autogonfiarsi, né più né meno degli “airbag” o dei canotti di
salvataggio in dotazione agli aerei, nel periodo che va dal dieci di
giugno alla riapertura delle scuole stesse: le sagre paesane.
Di tradizione antica ma di estrazione
plebea, le sagre – spesso rappresentate nella letteratura e nel
cinema – hanno costituito per decenni una delle poche, vere
occasioni di socializzazione. Antesignane di chiara impronta latina
dei social network e dei siti di incontri, potevano riassumersi in
una formula che comprendeva mangiate “en plen air”, bevute da
dromedario, ballo liscio (“lissio”, per la precisione) con
interpreti sempre uguali da Vipiteno a Pantelleria – la coppia di
novantenni bravissimi e atleticissimi, le due donne di mezza età (ma
anche tre quarti) che ballano insieme, una coppia di undicenni che
scimmiotta gli adulti -, un fienile a portata di … diciamo di mano,
e il tutto all'ombra della statua di un Santo o – in tempi più
recenti – di un palco da comizi,
Molte di queste sagre sono arrivate ai
giorni nostri, e ad esse si sono affiancate nuove e ben poco locali
tradizioni. Niente da eccepire, perciò, quando in Riviera è tempo
della sagra della Trofia, o in Valsecca esplode quella del salame.
Qualche dubbio sulla storia e sulla tradizione viene qualora, da
manifesti di colori normalmente agghiaccianti, si convochi l'universo
a presenziare alla “Sagra dell'asado” o alla “Sagra della
paella”, il più delle volte organizzate in località dove la meta
più esotica è rappresentata da Isola del Cantone (che, se non altro
– e non altro - è un'isola).
E finisco qui: abbiamo ancora una
decina di giorni, e qualche sagra possiamo ancora ragionevolmente
trovarla.
A proposito: da qualche parte ho letto
che domenica è prevista la “Sagra della patata”. Sono curioso...
MA PARLIAMO UN PO' DI NOI...
... e dei nostri romanzi:
https://www.facebook.com/groups/librichiacchereecaffe/permalink/2548701895358746/
Grazie, Gianluca Russo!
https://www.facebook.com/groups/librichiacchereecaffe/permalink/2548701895358746/
Grazie, Gianluca Russo!
CIAO, PRESIDENTE GIAN LUIGI!
Ci sono persone che, nella nostra vita,
ci appaiono come piccoli ologrammi silenziosi e discreti, che
sembrano non voler mai essere di turbamento ma non per questo non
lasciano segni indelebili lungo il proprio percorso.
Ecco, Gian Luigi Corti non apparteneva
a questa genia. Era un personaggio estremamente rumoroso, presente,
inarrestabile, come quei liquidi che invano si cerca di fronteggiare
con paratie e accorgimenti vari per evitarne l'invasione. Un lago
artificiale dalla volumetria ben superiore alla diga che avrebbe
provato a contenerlo. Impossibile non accorgersi di lui, delle sue idee, dei suoi progetti.
E' stato un maestro, un trascinatore,
un precursore, un profeta, un guerriero, fino agli ultimi giorni:
veloce di azione e ancor più di pensiero, intravvedeva cattedrali
dove altri contavano a malapena mucchi di pietre informi. Ha fatto
tanto, tantissimo, per il giornalismo ligure, capace di creare rete
ben prima e ben oltre internet, punto di contatto tra mondi che,
altrimenti, mai si sarebbero parlati. E ha fatto tantissimo per lo
sport italiano e genovese, in particolare per la pallavolo, tenendo a
battesimo i vittoriosi esordi internazionali di quel movimento che da
oltre quarant'anni è all'avanguardia nel mondo.
 Il Casellante piange oggi la scomparsa
di Gian Luigi Corti, al quale deve moltissimo, e più di ogni altra
cosa l'aver contribuito alla realizzazione di un sogno – essere
giornalista sportivo, esecitare la professione per la quale ci si
sente vocati anche quando la settimana lavorativa racconta storie
diverse, frequentare quelle stanze così sognate da ragazzo – con
le sue intuizioni, la sua generosità, la sua umanità, il suo
cercare soluzioni dove altri vedevano problemi e trasformare la
routine in avvincenti sfide.
Il Casellante piange oggi la scomparsa
di Gian Luigi Corti, al quale deve moltissimo, e più di ogni altra
cosa l'aver contribuito alla realizzazione di un sogno – essere
giornalista sportivo, esecitare la professione per la quale ci si
sente vocati anche quando la settimana lavorativa racconta storie
diverse, frequentare quelle stanze così sognate da ragazzo – con
le sue intuizioni, la sua generosità, la sua umanità, il suo
cercare soluzioni dove altri vedevano problemi e trasformare la
routine in avvincenti sfide.
Senza retorica, per chi volesse
approfondire la figura complessa e significativa di Gian Luigi, si
rimanda al bell'articolo letto oggi sull'edizione online del “Secolo
XIX”, che per un periodo fu anche la sua casa:
https://www.ilsecoloxix.it/sport/2019/09/05/news/lutto-nel-giornalismo-ligure-e-mancato-gianluigi-corti-1.37417138
Per il resto, Il Casellante si stringe
a Maria Carla, Paola e Michele in un caldo abbraccio. Non può
servire – le parole non bastano e non contengono – ma il solco
tracciato da colui che resterà per sempre il “Presidente” non si
cancellerà.
Etichette:
Fuoriclasse,
Siamo tutti sportivi
L'ASINOMETRO!
Ti hanno detto di leggere un documento in "modalità scrolling" e temi di doverlo fare alla toilette? Il tuo capo parla a malapena in dialetto ma non smette di spiegarti del nuovo "Business Model"? Allora ti aspetto venerdì 16 agosto alle 21.00 alla sala Riccio, a San Giacomo di Roburent (CN): ci divertiremo insieme giocando con i "Nuovi Mostri" della lingua italiana!
MA CONDIVIDERE SIGNIFICA DAVVERO "CONDIVIDERE"?
Sempre con l'intento di esorcizzare i
peggiori demoni che infestano le dinamiche organizzative, oggi ci
occupiamo di una famiglia di termini che sta godendo probabilmente
della fase di maggior fortuna da quando – oltre duemila anni fa –
è apparsa nei nostri vocabolari: quella del verbo “condividere”
e i suoi derivati “condivisione”, condiviso”, eccetera.
Come suggerisce l'etimologia,
“condividere” significa letteralmente “dividere con”, ossia
spartire, mettere a disposizione il nostro e poter usufruire
dell'altrui.
Nel millennio dei social, “condividere”
ha assunto una tonalità ulteriore: pubblicare un contenuto a
beneficio di terzi, il cui numero tende ad infinito. In alcuni casi
si tratta semplicemente di rendere noto il proprio attimo, a parole
ma più spesso con immagini, mentre in altri si tratta di richiamare
l'attenzione su un contenuto proprio o altrui. E' interessante notare
come questa pratica abbia poco di “condiviso”, trattandosi in
sostanza di un atto unilaterale con il quale si chiama a raccolta il
pubblico su un contenuto che si ritiene meritevole di conoscenza
diffusa. Non si tratta, in assoluto, di una pratica commendevole: se
così fosse queste righe che gli amici del “Casello” stanno
leggendo sarebbero in profonda contraddizione con sé stesse. E' però
una constatazione, una presa d'atto su come vadano le cose.
Dove però si tende a fare scempio del
significato più autentico della condivisione è nelle organizzazioni
strutturate e gerarchizzate.
Qui il più delle volte – ma verrebbe
da dire: sempre – chi comanda chiede ai sottoposti di “condividere”
un atteggiamento, un'idea, una strategia, e non certo nel senso di
“spartire” il proprio e l'altrui. Il senso invece è: voglio che
tu sia d'accordo che su questo punto si debba fare così.
E' assai diffusa la pratica di
“condividere” con i propri collaboratori una serie di concetti
calati dall'alto, che il ricevente deve semplicemente fare propri.
“Condividerli”, secondo il senso che se ne dà oggi in questo
genere di dinamiche.
L'aspetto bizzarro è che alla fine di
questo processo di imposizione di visioni e di strategie (non poi
dissimile dalla condivisione “social”) chi detiene ruoli apicali
sia effettivamente convinto di aver “condiviso” il cammino con i
propri sottoposti, semplicemente per averli messi a parte dei propri
programmi (“Volevo condividere con te la necessità che tu
faccia...”). Il che è l'esatto opposto della vera “condivisione”,
che – come rileva qualcuno – non si riferisce soltanto alla
propria “roba”, ma significa spartire con gli altri anche quello
che “è degli altri”.
Esistono studi ad ogni livello che
dimostrano come la vera “condivisione” - nella quale si può
ascoltare l'eco della congiunzione “con”, ma anche del sostantivo
“visione” - giovi profondamente a tutte le realtà organizzate,
dalla famiglia alla scuola, dall'associazionismo alla politica, e
fino al mondo del lavoro. Permette a ciascuno che se la senta di
mettersi in gioco, di assumersi reponsabilità, di collaborare per
ottenere risultati migliori. “Condivisione” significa, in ultima
istanza, dare e ricevere fiducia, investendo nelle persone e nelle
relazioni.
Ma questo salto di qualità culturale
presuppone la presenza al timone di figure che abbiano autorevolezza
e non semplice autorità, e che senza striduli isterismi siano
anzitutto in grado di ascoltare e non sentano insidiato il loro
ruolo, che altrimenti si riduce semplicemente al grado che ricoprono.
Il contrario di “condivisione”?
Eccolo: “Chiacchiere e distintivo”.
UN FALSO MITO, UN NEMICO SUBDOLO E VERO: LA MERITOCRAZIA.
Tutte le parole che portano la desinenza "-crazia" si accompagnano ad un rischio che pochi sono in grado di riconoscere: essere
mitizzate, assolutizzate e trasformate quindi in valori, quando in
realtà sono mezzi o, meglio ancora, metodi organizzativi.
È un discorso complesso, e sicuramente troveremo spazio e tempo per parlarne in futuro.
Oggi, al "Casello", ci vogliamo concentrare su una di queste parole, che sta diventando una sorta di mantra nel pubblico e nel privato, fino ad assurgere allo status di feticcio, sempre invocata come panacea di tutti i mali mentre, al contrario, si dimostra spesso un pericoloso strumento di indirizzo, controllo, inclusione e soprattutto esclusione sociale e individuale.
Questo parola è "meritocrazia".
È un concetto introdotto, con accezione negativa, dal sociologo inglese Young, sul finire degli anni cinquanta. E già questo avrebbe dovuto far comprendere molte cose.
Poi, come spesso capita per quanto di peggio offra ciò che proviene da cuiture del tutto estranee alla nostra tradizione, la meritocrazia è stata adottata, riconfigurata e promossa in prima linea da quella sorta di "senso comune" di manzoniana memoria, per il quale un concetto non è vero perché dimostrato, ma perché - rimbalzando da una portineria ad un salone da parrucchiere, fino a qualche interminabile riunione, meglio se a distanza - considerato vero da sempre più ampi cerchi concentrici di popolazione, per lo più di scarsa cultura e ancor meno buon senso. E, sia ben chiaro, a prescindere dal titolo di studio, che spesso - anzi - costituisce un'aggravante. E a prescindere persino dalla possibilità di effettivo accesso ai ruoli che si ambirebbe a ricoprire, giacché la meritocrazia è questione di élite. Anzi, è uno strumento in mano alle elite che ne hanno contaminato innumerevoli ambiti sociali partendo dal mondo degli affari, in concreto tra i meno meritocratici in assoluto, superato forse solo dalla politica, il cui principale criterio di allocazione degli spazi risulta essere - come sottolinea spesso Paolo, uno dei grandi amici del Casello (lui si riconoscerà) - quello della coda (chi è in lista d'attesa da più tempo).
Il governo di chi "merita" è un'utopia, ma se non lo fosse sarebbe la più crudele delle bugie. Perché non c'è nessuna oggettività nel concetto di merito, e quindi la meritocrazia sarebbe semplicemente il regime di chi risponde al meglio a criteri imposti da una regia più alta e remota.
È un discorso complesso, e sicuramente troveremo spazio e tempo per parlarne in futuro.
Oggi, al "Casello", ci vogliamo concentrare su una di queste parole, che sta diventando una sorta di mantra nel pubblico e nel privato, fino ad assurgere allo status di feticcio, sempre invocata come panacea di tutti i mali mentre, al contrario, si dimostra spesso un pericoloso strumento di indirizzo, controllo, inclusione e soprattutto esclusione sociale e individuale.
Questo parola è "meritocrazia".
È un concetto introdotto, con accezione negativa, dal sociologo inglese Young, sul finire degli anni cinquanta. E già questo avrebbe dovuto far comprendere molte cose.
Poi, come spesso capita per quanto di peggio offra ciò che proviene da cuiture del tutto estranee alla nostra tradizione, la meritocrazia è stata adottata, riconfigurata e promossa in prima linea da quella sorta di "senso comune" di manzoniana memoria, per il quale un concetto non è vero perché dimostrato, ma perché - rimbalzando da una portineria ad un salone da parrucchiere, fino a qualche interminabile riunione, meglio se a distanza - considerato vero da sempre più ampi cerchi concentrici di popolazione, per lo più di scarsa cultura e ancor meno buon senso. E, sia ben chiaro, a prescindere dal titolo di studio, che spesso - anzi - costituisce un'aggravante. E a prescindere persino dalla possibilità di effettivo accesso ai ruoli che si ambirebbe a ricoprire, giacché la meritocrazia è questione di élite. Anzi, è uno strumento in mano alle elite che ne hanno contaminato innumerevoli ambiti sociali partendo dal mondo degli affari, in concreto tra i meno meritocratici in assoluto, superato forse solo dalla politica, il cui principale criterio di allocazione degli spazi risulta essere - come sottolinea spesso Paolo, uno dei grandi amici del Casello (lui si riconoscerà) - quello della coda (chi è in lista d'attesa da più tempo).
Il governo di chi "merita" è un'utopia, ma se non lo fosse sarebbe la più crudele delle bugie. Perché non c'è nessuna oggettività nel concetto di merito, e quindi la meritocrazia sarebbe semplicemente il regime di chi risponde al meglio a criteri imposti da una regia più alta e remota.
In
rete sono reperibili molti saggi sulle storture indotte dall'assunzione
acritica della meritocrazia come chiave per il miglior funzionamento di
organizzazioni, istituzioni, scuole, aziende. Basta riflettere su quanta
incidenza abbiano il caso e le circostanze favorevoli, che il tifoso
della meritocrazia tende, con malizia o con superficialità, ad ignorare.
Ma senza tornare ad Aristotele o a Sant'Agostino e alla sua
intelligente demolizione dell'eresia pelagiana sono sufficienti alcune
riflessioni sparse.
Intanto, la prima cosa che salta agli occhi è che il cosiddetto "merito" non è una categoria oggettiva, in altre parole definendosi - eterogenesi dei fini - come il contrario di quanto vorrebbe rappresentare. La valutazione del merito parte dal presupposto che il "meritante" sia in linea con ciò che ci si attende da lui, che compia solo ed esclusivamente - possibilmente in modo acritico - quanto gli viene richiesto, con la prospettiva di essere premiato o non riprovato; e non che sia una persona capace, abile o talentuosa (attenzione, amici che state seguendo questo spunto, a questi aggettivi: sono la tesi di fondo, nonché tenaci avversari del "merito").
Sì innesca quindi un meccanismo perverso, in base al quale solo alcuni comportamenti possono "meritare", e dalla parte del "meritante" sorge una specie di diritto al riconoscimento del merito, vissuto come una forma di giustizia retributiva e come iniquità quando ciò non accade, mentre il "non meritante" vive la doppia frustrazione da un lato di sentirsi escluso e, in qualche modo, spesso vilipeso, e dall'altro di non vedere riconosciute le proprie qualità, perché considerate inutili alla causa.
Il talento è un dono, non un merito. Se invece si iniziano a considerare il talento e le capacità come un merito, selezionandone soltanto alcuni di più immediato ed utilitaristico impiego, va da sé che l'incapacità o la presenza di abilità non considerate funzionali diventano automaticamente demeriti, e - in buona sostanza - colpe. Ecco quindi la meritocrazia assurgere allo status di legittimazione etica della diseguaglianza. Una diseguaglianza, va aggiunto, legata all'accesso al potere, non alle qualità dei singoli. Perché va comunque detto che è diseguaglianza sia trattare in modo differente situazioni tra loro uguali, sia trattare in modo uguale situazioni differenti (il peccato mortale di ogni generalizzazione e di qualsiasi forma di massificazione).
Non è un fenomeno nuovo, anche se oggi vive una fase di forte espansione. In un periodo storico dove appare evidente la volontà di far sentire scomode le persone sulle sedie che occupano, il talento è pericoloso perché sa fare cose diverse rispetto al cliché dominante. Se non si trova il modo di utilizzarlo nell'alveo del prestabilito - quanta ottusità materialista in questa immagine! - va semmai ostacolato, limitandolo o minimizzandolo.
Esiste poi un numero crescente di studi che dimostrano come il credere nella meritocrazia non sia soltanto fallace, ma renda gli individui più gretti, egoisti, autocratici, poco inclini all'autocritica e impermeabili alla verifica costruttiva del proprio operato.
In realtà gli antidoti contro l'usurpata egemonia del merito esistono, e sono di due specie. La prima è costituita dal talento, dalla capacità, dalla conoscenza, dall'abilità, e guarda il merito dall'alto. Non si tratta di una caratteristica unitaria, perché tantissimi sono per l'appunto i talenti, le capacità, le conoscenze, le abilità. La cosiddetta "meritocrazia" vive crogiuolandosi nel proprio potere autoreferenziale - qualcuno dice icasticamente "autocongratulante" - di promuovere alcune - poche - capacità e di ignorarne (quando non stroncarne) molte altre. Ma è sufficiente riflettere su quanti talenti oggi non vengono utilizzati, anche quando sarebbero utilissimi: la mitezza, la riflessività, oppure la capacità di comporre i conflitti, o la dialettica, solo per citarne alcuni.
Appare evidente, quindi, che la "qualitocrazia" costituirebbe una ben più efficace svolta sociale e organizzativa.
La seconda specie guarda alla meritocrazia dal basso, e diventa talvolta un grido di dolore, quasi sempre inascoltato: è la gratuità. Chi non merita - e abbiamo capito cosa significa davvero "meritare" - rimane indietro. Non dispone di mezzi, di accesso, di visibilità, di opportunità, e per giunta è spesso vittima di pregiudizio e preconcetto. Alla valutazione sulla mancanza di merito si associa sovente quella sulla mancanza di qualità, una sorta di riprovazione morale per non aver meritato, mischiando nello stesso calderone due ingredienti che, invece, appartengono a categorie quasi opposte.
La gratuità è la vera, grande nemica della meritocrazia, che la combatte e la evita. Nei meritocrati più intelligenti (e perfidi), negandole gli spazi; nei replicanti più ottusi, immaginando sempre chissà quale dietrologia porti con sé la proposta disinteressata e diversa.
Gratuità e talento sono parenti stretti, perché il talento è dono. Il merito è, al contrario, l'illusione di avercela fatta da soli, il reclamare una retribuzione per la propria volontà di assecondare.
Pensare che il merito - e non le qualità (tecniche ma soprattutto umane) - possa risolvere i problemi del nostro tempo è come affidare alla Banda Bassotti le proprie finanze. Sappiamo già come andrà a finire.
Intanto, la prima cosa che salta agli occhi è che il cosiddetto "merito" non è una categoria oggettiva, in altre parole definendosi - eterogenesi dei fini - come il contrario di quanto vorrebbe rappresentare. La valutazione del merito parte dal presupposto che il "meritante" sia in linea con ciò che ci si attende da lui, che compia solo ed esclusivamente - possibilmente in modo acritico - quanto gli viene richiesto, con la prospettiva di essere premiato o non riprovato; e non che sia una persona capace, abile o talentuosa (attenzione, amici che state seguendo questo spunto, a questi aggettivi: sono la tesi di fondo, nonché tenaci avversari del "merito").
Sì innesca quindi un meccanismo perverso, in base al quale solo alcuni comportamenti possono "meritare", e dalla parte del "meritante" sorge una specie di diritto al riconoscimento del merito, vissuto come una forma di giustizia retributiva e come iniquità quando ciò non accade, mentre il "non meritante" vive la doppia frustrazione da un lato di sentirsi escluso e, in qualche modo, spesso vilipeso, e dall'altro di non vedere riconosciute le proprie qualità, perché considerate inutili alla causa.
Il talento è un dono, non un merito. Se invece si iniziano a considerare il talento e le capacità come un merito, selezionandone soltanto alcuni di più immediato ed utilitaristico impiego, va da sé che l'incapacità o la presenza di abilità non considerate funzionali diventano automaticamente demeriti, e - in buona sostanza - colpe. Ecco quindi la meritocrazia assurgere allo status di legittimazione etica della diseguaglianza. Una diseguaglianza, va aggiunto, legata all'accesso al potere, non alle qualità dei singoli. Perché va comunque detto che è diseguaglianza sia trattare in modo differente situazioni tra loro uguali, sia trattare in modo uguale situazioni differenti (il peccato mortale di ogni generalizzazione e di qualsiasi forma di massificazione).
Non è un fenomeno nuovo, anche se oggi vive una fase di forte espansione. In un periodo storico dove appare evidente la volontà di far sentire scomode le persone sulle sedie che occupano, il talento è pericoloso perché sa fare cose diverse rispetto al cliché dominante. Se non si trova il modo di utilizzarlo nell'alveo del prestabilito - quanta ottusità materialista in questa immagine! - va semmai ostacolato, limitandolo o minimizzandolo.
Esiste poi un numero crescente di studi che dimostrano come il credere nella meritocrazia non sia soltanto fallace, ma renda gli individui più gretti, egoisti, autocratici, poco inclini all'autocritica e impermeabili alla verifica costruttiva del proprio operato.
In realtà gli antidoti contro l'usurpata egemonia del merito esistono, e sono di due specie. La prima è costituita dal talento, dalla capacità, dalla conoscenza, dall'abilità, e guarda il merito dall'alto. Non si tratta di una caratteristica unitaria, perché tantissimi sono per l'appunto i talenti, le capacità, le conoscenze, le abilità. La cosiddetta "meritocrazia" vive crogiuolandosi nel proprio potere autoreferenziale - qualcuno dice icasticamente "autocongratulante" - di promuovere alcune - poche - capacità e di ignorarne (quando non stroncarne) molte altre. Ma è sufficiente riflettere su quanti talenti oggi non vengono utilizzati, anche quando sarebbero utilissimi: la mitezza, la riflessività, oppure la capacità di comporre i conflitti, o la dialettica, solo per citarne alcuni.
Appare evidente, quindi, che la "qualitocrazia" costituirebbe una ben più efficace svolta sociale e organizzativa.
La seconda specie guarda alla meritocrazia dal basso, e diventa talvolta un grido di dolore, quasi sempre inascoltato: è la gratuità. Chi non merita - e abbiamo capito cosa significa davvero "meritare" - rimane indietro. Non dispone di mezzi, di accesso, di visibilità, di opportunità, e per giunta è spesso vittima di pregiudizio e preconcetto. Alla valutazione sulla mancanza di merito si associa sovente quella sulla mancanza di qualità, una sorta di riprovazione morale per non aver meritato, mischiando nello stesso calderone due ingredienti che, invece, appartengono a categorie quasi opposte.
La gratuità è la vera, grande nemica della meritocrazia, che la combatte e la evita. Nei meritocrati più intelligenti (e perfidi), negandole gli spazi; nei replicanti più ottusi, immaginando sempre chissà quale dietrologia porti con sé la proposta disinteressata e diversa.
Gratuità e talento sono parenti stretti, perché il talento è dono. Il merito è, al contrario, l'illusione di avercela fatta da soli, il reclamare una retribuzione per la propria volontà di assecondare.
Pensare che il merito - e non le qualità (tecniche ma soprattutto umane) - possa risolvere i problemi del nostro tempo è come affidare alla Banda Bassotti le proprie finanze. Sappiamo già come andrà a finire.
L'AMBIENTALISMO COLLATERALISTA DI CASA NOSTRA
Da molto tempo il Casellante è arrivato alla conclusione che certe associazioni "ambientaliste" siano, in realtà, autentiche quinte colonne di ciò che resta della sinistra massimalista.
Apriorismi, battaglie contro il progresso, scelte incomprensibili (dov'erano questi signori quando si costruiva una delle reti autostradali più estese d'Europa, o quando si regalavano all'autotrasporto merci autentiche praterie? Ah, già... erano dei "loro"...): c'era un tizio, una macchietta, reponsabile di una delle principali associazioni del ramo (è il caso di dirlo), che a inizio duemila si era reso famoso - e ridicolo, ma pur essendo una caricatura non faceva ridere nessuno, ed era anche piuttosto irascibile - per le sue posizioni di retroguardia su Terzo Valico, nuove linee, eccetera. E la crisi del 2008 era ancora di là da venire.
Ma, vuole un antico adagio, il lupo perde il pelo ma non il vizio. E così, eccoli a sbottare, questa volta contro il prolungamento della metropolitana di Genova. Uno se li aspetterebbe a favore, e magari in crociata contro moto, furgoni, mamme al volante nelle ore di punta. Invece no: perchè la validità del mezzo da utilizzare è anzitutto soggettiva. L'avesse proposta qualcuna delle sciagurate giunte precedenti alti sarebbero saliti i peana. Ma la conclusione dell'iter è legata alla giunta Bucci, e quindi è sbagliata la scelta.
Non ne possiamo più. Ma coviamo la segreta speranza che prima o poi l'ambiente, l'habitat naturale, faccia il suo dovere...
https://www.facebook.com/giuseppe.viscardi.94/posts/10217105205615186?comment_id=10217105739388530¬if_id=1557427785685118¬if_t=feed_comment
UN ALLENATORE COI FIOCCHI
Devo dire la verità: quando fu annunciato l'arrivo alla Sampdoria di Marco Giampaolo, al posto di Vincenzo Montella (destinato al Milan, liberato da una clausola capestro con la Fiorentina grazie ad un colpo di mano di Ferrero, e adesso - ironia della sorte - nuovamente sulla panchina viola), beh, ero sicuramente tra gli scettici. Avevo davanti agli occhi episodi che, sommati, mi facevano pensare fosse una scelta rischiosa, a dir poco. Esoneri a raffica, fughe con certificato medico, carattere indecrittabile, e ci sarebbe da continuare.
Giorno dopo giorno, partita dopo partita, e sono ormai tre anni, questo allenatore mi ha davvero conquistato. Mi piace quando allena, quando siede in panchina, quando parla davanti ai microfoni di partite da compiersi o già agli archivi, oppure quando discetta di altro, ad esempio di cosa significhi il mestiere di allenatore al giorno d'oggi.
 Poco alla volta non solo ho imparato ad apprezzarne le qualità tattiche, non solo ho imparato a cercare, in campo, i dettagli dei suoi dogmi - la difesa schierata in linee perfette, il centrocampista centrale che si fa vedere, le mezze ali che corrono ad accorciare il campo in senso longitudinale, e via continuando - ma ho imparato persino ad apprezzare i suoi limiti, a comprendere i suoi (eventuali) errori, a giustificare le imbarcate - grandi e piccole - che la sua Sampdoria continua a prendere, anche quando magari non te lo aspetteresti.
Poco alla volta non solo ho imparato ad apprezzarne le qualità tattiche, non solo ho imparato a cercare, in campo, i dettagli dei suoi dogmi - la difesa schierata in linee perfette, il centrocampista centrale che si fa vedere, le mezze ali che corrono ad accorciare il campo in senso longitudinale, e via continuando - ma ho imparato persino ad apprezzare i suoi limiti, a comprendere i suoi (eventuali) errori, a giustificare le imbarcate - grandi e piccole - che la sua Sampdoria continua a prendere, anche quando magari non te lo aspetteresti. Così, prima che sia tardi e anche questo campionato debba essere destinato agli almanacchi, ci tengo a fare outing e a professarmi, qui davanti al "Casello", un Giampaoliano fatto e finito. A bearmi della sua ennesima vittoria contro i rivali cittadini tetramente bicolori, e a non dolermi più di tanto dell'infausto secondo tempo di Bologna, campo sul quale conto di vederlo vincere prima o poi, vista la poca simpatia che nutro per città, popolazione, tifoseria, squadra (e colori sociali).
Così, prima che sia tardi e anche questo campionato debba essere destinato agli almanacchi, ci tengo a fare outing e a professarmi, qui davanti al "Casello", un Giampaoliano fatto e finito. A bearmi della sua ennesima vittoria contro i rivali cittadini tetramente bicolori, e a non dolermi più di tanto dell'infausto secondo tempo di Bologna, campo sul quale conto di vederlo vincere prima o poi, vista la poca simpatia che nutro per città, popolazione, tifoseria, squadra (e colori sociali).
A tenere banco, in queste settimane, è la possibilità che la Sampdoria cambi padrone. Non ho elementi per esprimermi nè in un senso - credo sia incontestabile che Ferrero, bravo e/o fortunato, abbia lavorato bene nel suo quinquennio, e non mi sembra giusto fare paragoni con dirigenze passate, tutte a loro modo apprezzabili - nè nell'altro. Un auspicio, però, lo butto lì: mi piacerebbe che, al ritiro di luglio, a guidare il pullman della squadra verso le Alpi sia ancora un autista abruzzese nato a Bellinzona.
IL GANCIO TENDITORE
 Il gancio tenditore a vite è
quell'organo di accoppiamento – non fraintendetemi, fa già
abbastanza fatica il Casellante a resistere ai doppi sensi – che in
ferrovia serve a collegare un rotabile ad altri, per comporre un
convoglio.
Il gancio tenditore a vite è
quell'organo di accoppiamento – non fraintendetemi, fa già
abbastanza fatica il Casellante a resistere ai doppi sensi – che in
ferrovia serve a collegare un rotabile ad altri, per comporre un
convoglio. Ne sono dotati i mezzi di trazione, le carrozze passeggeri, i carri merci, i veicoli di servizio. Più volte seppellito dai progressisti della rotaia, in realtà gode di salute eccellente, e ad eccezione di applicazioni molto specializzate – Alta Velocità, metropolitane, tram – continua ad esercitare una funzione umile ma imprescindibile sui binari di tutto il mondo.
E... niente: esiste un gancio tenditore
che colleghi tra di loro i tre romanzi del Casello? “Il casello
nascosto tra gli alberi”, “Troppo tardi”, “...Ti regalo una
città”, sono vagoni di uno stesso treno?
 Espressa così (espressa... quanti
termini ferroviari...) sembra una domanda retorica. E' ovvio,
l'autore è – immodestamente - lo stesso, e ogni artigiano della
parola ha quel tocco che contrassegna sempre la sua bottega.
Espressa così (espressa... quanti
termini ferroviari...) sembra una domanda retorica. E' ovvio,
l'autore è – immodestamente - lo stesso, e ogni artigiano della
parola ha quel tocco che contrassegna sempre la sua bottega.
Però, in questo periodo di
presentazioni – a proposito, stanno per arrivarne altre: giovedì 4
aprile a Genova, domenica 7 aprile a Trecate (Novara) -, capita
spesso di riflettere su cosa ci sia davvero di comune alle tre
storie. Perchè c'è sempre qualcuno che te lo chiede. E' una delle
tre domande alle quali non si può sfuggire (le altre sono: “quanto
c'è di te nei protagonisti?”, e “stai già pensando ad un'altra
storia?”),
Il fatto è che invece chi inventa il
suo mondo parallelo e lo posa sulle pagine di un libro a queste cose
non pensa. Sicuramente non “prima” e nemmeno “durante”. Chi
crea un mondo di parole e lo fa diventare persone e personaggi,
posti, situazioni, non si rappresenta il nesso, il danno o la
potenzialità data dal regalare pezzi di strada (ferrata, nel nostro
caso) in comune a quella e ad altre storie, sempre che non sia uno di
quegli autori seriali che puntano con baldanza su un cavallo, per
quanto di razza (I Dirk Pitt di Clive Cussler, gli Hercule Poirot di
Agatha Christie), oppure gli emulatori di proprie o altrui creazioni.
 Può essere invece che ci si pensi
“dopo”. Succede, eh? La domanda che ti arriva dal pubblico –
che è lì per te, spesso sono amici, se sei lontano li vedi
raramente, e quindi hanno diritto di voler sapere tutto – ti suona
sempre nuova e ti fa riflettere. Ma io, ho un messaggio da portare?
Voglio raccontare qualcosa di speciale nei miei libri, oltre alla
storia che si materializza nel susseguirsi delle pagine? C'è
qualcosa scritto al di fuori delle righe nere – quelle che
contengono le parole – che magari senza volerlo chi ti legge sa
cogliere, e tu non volevi forse nemmeno dirlo, ma lo hai fatto lo
stesso e qualcuno è stato così bravo da trovarlo? E questo
eventuale e farraginoso messaggio è in contraddizione o in
continuità con sé stesso, viaggiando attraverso tre libri?
Può essere invece che ci si pensi
“dopo”. Succede, eh? La domanda che ti arriva dal pubblico –
che è lì per te, spesso sono amici, se sei lontano li vedi
raramente, e quindi hanno diritto di voler sapere tutto – ti suona
sempre nuova e ti fa riflettere. Ma io, ho un messaggio da portare?
Voglio raccontare qualcosa di speciale nei miei libri, oltre alla
storia che si materializza nel susseguirsi delle pagine? C'è
qualcosa scritto al di fuori delle righe nere – quelle che
contengono le parole – che magari senza volerlo chi ti legge sa
cogliere, e tu non volevi forse nemmeno dirlo, ma lo hai fatto lo
stesso e qualcuno è stato così bravo da trovarlo? E questo
eventuale e farraginoso messaggio è in contraddizione o in
continuità con sé stesso, viaggiando attraverso tre libri?
Oggi, al Casello, non abbiamo ancora
deciso se esistono risposte. Non sappiamo se a percorrere i binari
posati qui davanti sia una littorina isolata o un treno con
locomotiva e vagoni, tenuti insieme con il gancio tenditore a vite.
Ci rifletteremo insieme, e il Casellante sarà grato a chi vorrà
aiutarlo a comporre o scomporre il convoglio di carta.
IL MISTERO DEL PASSO DYATLOV - SESSANT'ANNI DI OMBRE
E' stata sicuramente la più misteriosa e tragica spedizione scialpinistica di tutti i tempi, eppure ancora pochi sono coloro che conoscono le vicende di questi nove ragazzi russi, dapprima scomparsi e poi ritrovati morti sui monti Urali, nella parte centrale dell'allora URSS.
Era il febbraio 1959, ed un gruppo di studenti dell'Università di Ekaterinburg, alcuni già laureati (per lo più in ingegneria), altri in dirittura finale, aveva deciso di compiere un'escursione lungo una zona impervia e in larga parte inesplorata nel nord della catena degli Urali.
Percorsa la prima parte del tragitto in treno e autocarro, lasciato uno dei compagni all'ultimo avamposto abitato a causa di un'indisposizione (che gli avrebbe salvato la vita), i nove si erano avventurati sulle pendici del Monte Otorten. Avrebbero telegrafato a casa una volta compiuta la traversata, che prevedeva marce con gli sci e notti in tenda con temperature fino a - 30°.
Era l'Unione Sovietica di Kruscev, che tentava di scrollarsi di dosso la patina grigio sangue dello stalinismo con nuove aperture (la cosiddetta "distensione") e una ritrovata vitalità, che questi giovani sembravano voler interpretare.
Quel telegramma non arrivò mai. Passate alcune settimane, le famiglie esercitarono pressioni perchè le autorità iniziassero a cercare i ragazzi. Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo le squadre di soccorso individuarono la tenda, vuota e - si disse nei testi ufficiali - squarciata dall'interno.
Dalla tenda partivano una serie di impronte, otto o nove paia, alcune lasciate da persone senza calzature, che però scomparivano cinquecento metri più avanti. Sotto un grande cedro, a circa un chilometro e mezzo, furono rinvenuti i primi due corpi. Lungo il pendio, qualche giorno dopo, ecco altri tre cadaveri, girati come se i ragazzi stessero tentando (nella notte, con temperature proibitive e senza alcuna visibilità) di rientrare all'accampamento. Degli altri quattro nessuna traccia, fino al disgelo: erano collocati in una specie di rifugio nella neve, sulle rive di un ruscello, morti anch'essi.
Molti di loro presentavano ferite le più diverse, alcune fatali, altre no. Ma nessuna spiegazione ebbe mai il pregio di risultare definitiva.
 Di sicuro c'è solo che qualcosa, o qualcuno, li indusse a lasciare il caldo tepore del rifugio notturno per mettersi al riparo da... cosa? Forse nessuno lo saprà mai.
Di sicuro c'è solo che qualcosa, o qualcuno, li indusse a lasciare il caldo tepore del rifugio notturno per mettersi al riparo da... cosa? Forse nessuno lo saprà mai.
Si parlò di UFO, di Yeti, di manovre militari, di incidenti, di valanghe, di follia collettiva. Nessuna spiegazione, a tutt'oggi, toglie spazio a dubbi e incongruenze. La scena della tragedia venne fortemente contaminata dalle squadre di soccorso, e molti elementi utili all'indagine scomparvero con i ragazzi.
Non intendiamo qui dilungarci, anche perchè sul web esiste una lunga sfilza di teorie, anche bislacche, su come fossero potute andare effettivamente le cose.
Segnaliamo qui il sito più accreditato dove, anche a distanza di sei decenni, tanti appassionati cercano di ricostruire questa incredibile vicenda:
https://dyatlovpass.com/
A noi preme soprattutto perpetuare il ricordo di questi sfortunati ragazzi, che sfidarono gli elementi con un'impresa ritenuta audace e che invece si rivelò fatale. Un pensiero a loro, e alle loro famiglie.
SANREMO: UNA MODESTA PROPOSTA
Cala il sipario sulla sessantanovesima edizione del Festival per antonomasia, conosciuto in tutto il mondo non solo e non tanto per la divulgazione della musica italiana, quanto per la parata di ospiti internazionali la cui presenza nobilita il palco dell'Ariston e che - spesso - nella storia ha visto autentiche perle.
Un'edizione decisamente sottotono, va detto. Molto peggiore, senza andare lontano, delle tre che l'hanno preceduta. Imbarazzata e imabarazzante la presentazione, disguidi tecnici e buchi temporali come nemmeno alla Sagra del Frisciolo, livello musicale scadente sia nella presenza, sia nella qualità.
Al Casello, si sa, un po' di musica la mastichiamo, e vorremmo addentrarci anche in disquisizioni tecniche, ma sarebbe un addentrarci pericoloso, perchè la soggettività del giudizio in campo artistico fa sembrare brutto ciò che è bello e viceversa, oppure piace a Tizio ciò che ripugna a Caio, in un mescolio di età, sesso, gusti, geografia che non permette di esprimere, in definitiva, giudizi che possano avere pretesa di oggettività.
Così ci buttiamo a dire che, a parer nostro, è evidente l'invadenza del rap a scapito della musica e soprattutto del canto in senso tecnico. Un'invadenza che non rispecchia affatto le percentuali di diffusione e di gradimento tra le due tecniche. Non è un giudizio di merito, ma una semplice constatazione.
Sempre a giudizio del Casellante, i cosiddetti "big" ai nastri di partenza erano davvero pochi. Non è un fenomeno nuovo: fin dalla seconda metà degli anni settanta la rincorsa alla pedana sanremese da parte dei mostri sacri ha conosciuto fasi alterne ma comunque in chiaro ribasso rispetto alle origini, quando si veniva notati - avrebbe detto Nanni Moretti - sia nell'esserci, sia nel mancare. Ma mai come quest'anno beniamini del pubblico se ne sono visti pochi, e per giunta - tolta Loredana Bertè, che sembra una caricatura ma è arrivata al Festival con una canzone finalmente credibile e all'altezza del suo passato - con brani che non rimarranno impressi nel marmo.
Ancora: è evidente che l'ospizio non è più produttivo. L'anno scorso Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, quest'anno Patty Pravo, i nonnetti vanno incontro a magre figure. D'altra parte, a pensarci bene, all'epoca dei trionfi di Gigliola Cinquetti, Bobby Solo e Adriano Celentano, le Nille Pizzi e i Luciano Tajoli se ne guardavano bene dal credersi competitivi.
Si può fare meglio? Sì. I modi potrebbero essere millanta, che tutta notte canta, è il caso di dire. Ma una proposta verrebbe da farla: perchè non tornare alle coppie, come negli anni più fortunati? Lo stesso brano proposto da due esecutori diversi: due italiani, magari uomo e donna, oppure un complesso, e un solista, o ancora un big di casa nostra e una star internazionale.
Non credo potrebbe essere peggio di adesso. E, forse, si assisterebbe al recupero della musica e del canto sul testo recitato su basi sincopate e distoniche.
"... TI REGALO UNA CITTA'" VA A TORINO
Continua la tournèe del terzo romanzo del Casello.
Venerdì 15 febbraio "...Ti regalo una città" sarà a Torino, ospite dei Bagni Pubblici di via
Agliè, in via Agliè 9, zona Barriera di Milano, alle ore
18,30.
L'amico Giulio Lucci farà da relatore,
e sarà un'occasione per tanti amici per rivedersi.
Ecco il link alla pagina Facebook
dell'evento:
LE LETTURE DI "...TI REGALO UNA CITTA'" SU YOUTUBE
Il Casellante ospita l'autore dei romanzi del Casello, che legge per noi alcuni brani del suo ultimo romanzo, "...Ti regalo una città", che così tanto sta piacendo a chi lo ha letto.
Ecco il canale a cui collegarsi:
https://www.youtube.com/channel/UCBIbNoKk9auUheoUzUqPwog?view_as=subscriber
Iscriviti a:
Commenti (Atom)